Erostrato fu un fallito della metà del 300 a. C. che per rendersi famoso incendiò e distrusse il celeberrimo tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo antico. Lo condannarono a morte e decretarono che non venisse mai ricordato il suo nome, e così fu, nell’antichità.
In una concezione moderna, per “erostratismo si intende quindi un’ansia smaniosa di passare alla storia, anche scrivendo falsità sull’onore delle persone che se non provate sono passibili di querele”. Come spesso riportato in libera traduzione, anche nell’attualità ci sono molti Erostrati che molto più praticamente devono buttare merda sugli altri per abbassarli al proprio livello.
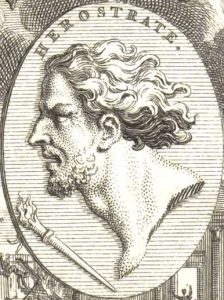
Questa caratteristica è predominante in parecchi sedicenti intellettuali della gauche caviar, in quegli intoccabili opinionisti progressisti, secondo la cui dottrina qualunque altro pensiero non conforme al loro, non importa di quale e di quanta importanza, deve essere accusato di distorsione concettuale, quando non affetto da una più banale ignoranza, arrivando a criminalizzarlo e a mostrificarlo.
Essi sono affetti da quei disturbi cognitivi che sono propri di ognuno di noi, ma con una differenza sostanziale nella consapevolezza della loro esistenza. In senso molto pratico e concreto: ciascuno dovrebbe porsi la domanda se una sua considerazione, se un suo giudizio, se una sua qualunque valutazione su fatti e persone siano da considerarsi oggettivamente comprovati, oppure inquinati da pregiudizi e da credenze falsificanti.
Facile a dirsi, perché questa operazione di consapevolezza e di introspezione presuppone una serie di domande rivolte a se stessi: “Sono disposto a mettere in discussione le mie certezze?”; “Quanto mi può costare, dal punto di vista psicologico, riconoscere i miei errori?”; “Quanto la mia personalità e il mio carattere sono fondati su false credenze?”; “Quanto la mia autostima è pericolosamente precaria?”. In psichiatria e in psicoanalisi, questa attitudine si chiama tecnicamente insight, ovvero la percezione e il discernimento dei propri stati d’animo, dei ragionamenti interiori e delle motivazioni del proprio comportamento. Ogni professionista sa, per studio e per lavoro, che senza acquisti presupposti interrogativi non c’è possibilità di approccio per nessun tipo di terapia e, soprattutto, non c’è alcuna opportunità di cambiamento. Quando qualcuno esordisce dicendo “Mi conosco fin troppo bene” è la volta buona per capire che tanto è di nascosto, è tanto da scoprire.
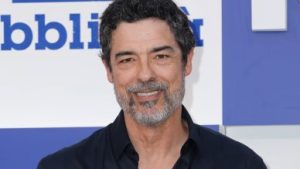
Peraltro c’è una battuta che mi è capitato spesso di usare, fatta da un mio docente e poi amico, il quale mi disse: “Se bastasse l’intelligenza, la cultura, la volontà razionale e la possibilità economica per risolvere i problemi psichici a noi chi ci pagherebbe il mutuo?”.
Questa panoramica falsificatoria e travisante di molte realtà che vengono spacciate dai diversi guru della misinformazione è opportuna mantenerla in una cornice di tipo psicologico, perché se poi ci si addentra in interessi di carattere commerciale, carrieristico o di compiacimento pubblico, la deriva è quella etica della disonestà e della malafede.
Parliamo molto banalmente di quelli che vengono definiti bias cognitivi, i più svariati automatismi mentali a causa di quali si creano false credenze, si cercano solo conferme alle proprie convinzioni, si tende – con una conseguenza ovvia – a negare tutte le eventuali evidenze contrarie e a confermarsi sempre come corretti interpreti della realtà.
Queste ed altre alterazioni sia nell’analisi dei fatti sia nella comunicazione dei medesimi è particolarmente diffusa, e conseguentemente pericolosa.
In ambito giornalistico, gli anglosassoni invitano ad applicare la regola delle 5W – Who (chi), How (come), Where (dove), When (quando) e Why (perché) – nell’approccio all’esame dei fatti. In altri contesti, meno pratici e per certi versi anche meno comuni – storici, filosofici, economici o strategici ecc. – vengono consigliati tre paradigmi di criticità.

Il primo è il dubbio sistematico, quello che il grande matematico Bruno de Finetti considerava essenziale per qualunque procedura che avesse l’obiettivo della razionalità e della ricerca della verità, o quantomeno di una conoscenza seria della questione in esame – verificare la fonte, le motivazioni incerte quando non ambigue, il margine di veridicità, la provenienza dell’informazione, la razionalità rigorosa, gli interessi in gioco.
Il secondo è la coscienza critica, ovvero la valutazione delle osservazioni disponibili, l’esclusione di interessi ambigui, la conferma dei dati acquisiti.
Il terzo è la disposizione a sospettare, da considerarsi una qualità da praticare positivamente per esaminare approfonditamente ogni ipotizzata verità che il sistema, o le più diverse agenzie o gruppi di appartenenza, dispensano e ordinano con evidenza categorica e inossidabile; una virtù esattamente opposta alla posizione paranoica che si affanna a denunciare ogni possibile complotto che mette in discussione le proprie deliranti certezze.
Se questi metodi e questi procedimenti venissero applicati anche nel piccolo quotidiano delle comunicazioni sui social, forse qualche laureato in cantautori sarebbe più cauto nelle sue valutazioni politiche; forse qualche strimpellatore da sagra paesana dimostrerebbe un po’ più di correttezza nel non inseguire certezze altrui per confermare le scadenti proprie, a proposito di direttori di orchestra; forse qualche cattedratico farebbe meglio ad applicare già a se stesso quella disponibilità al confronto che per supponenza nega agli altri non degni di parola; forse qualche fenomeno dall’opinionismo un tanto al chilo sarebbe meno supponente nel parlare di diritto internazionale marittimo e non.
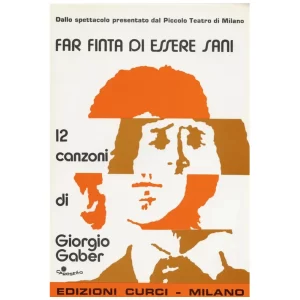
Forse…forse…forse…, ma questo avverbio è destinato a rimane inutilizzato, perché è molto più facile gratificante “Far finta di essere sani”, secondo la splendida esibizione di Gaber, che mettere in discussione – per dirla in termini clinici – il proprio Falso-Sé, la tanto supponente quanto fragile personalità.