“Noi siamo stati sedotti dalla comodità”, ha argomentato Paolo Crepet in un coinvolgente incontro pubblico che aveva come sfondo un manifesto con la scritta “I social come via breve per rimbecillirsi”. Due affermazioni che non sono un facile cortocircuito sulle cause del decadimento culturale e cognitivo – sarebbe in contraddizione con il giudizio complessivo che è stato sviluppato –, ma due precisazioni dalle quali partire per affrontare il problema complesso della comunicazione omologata: l’aspetto della psicologia individuale e sociale, da un lato, e quello della simbolica politica, dall’altro.
Si potrebbe considerarli anche due avvertimenti che come nell’ultimo evento, quale il “caso Maduro”, vengono sempre ampiamente trascurati e trasgrediti nei commenti generali.
Un tempo la scuola partecipava alla maturazione del giovane attraverso un progressivo allenamento alla memoria, alla ricerca, all’approfondimento e alla sintesi del giudizio.
Racconta di quando un docente di Filosofia estetica all’università ricevette un avviso ministeriale con il quale si decretava che tutti i testi entro le 500 pagine dovevano essere riassunti, e confrontava questo approccio quando lui – noi, per età e facoltà universitaria – affrontavamo le cosiddette “mediche”, la patologia e la clinica, memorizzando un totale intorno alle 6000 pagine da portare all’esame in un colpo solo. Niente menti eccezionali, ma solo anni e anni di addestramento delle abilità cerebrali.
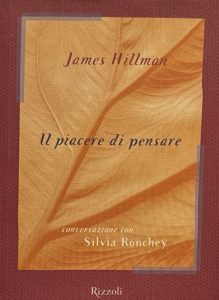
Al lento decadimento della funzione educativa per una scelta voluta di incentivazione alla melassa informativa e alla mediocrità culturale, ad un certo momento come aggravante del degrado fu l’immissione nel mercato del computer, prima, e dello smartphone, poi.
Da quella circostanza si dispiegarono a cascata una serie di conseguenze individuali e sociali difficili da contenere.
Intanto, quel processo che va sotto il termine di “infarinatura”, con l’effetto di una diffusa superficialità nell’osservazione della realtà e degli eventi che in essa si manifestano. Il procedimento che dovrebbe precedere qualunque tipo di giudizio, e che come base dovrebbe avere il sufficiente tempo di ascolto, meglio ancora se condensato in silenziosi appunti mentali, è stato rapidamente sostituito dal sentire meccanico e facilitato, perfettamente associato alla risposta immediata e non meditata identificabile con il simbolico “like”. Un automatismo facile e irresponsabile, perché non deve essere articolato e documentato da un procedimento di analisi, di confronto e di sintesi, ma molto più semplicemente da una condivisione immediata ispirata da un’emotività priva di filtri.
Questo procedimento, poi, si inserisce all’interno di quella mentalità che Crepet definisce con precisione come “cibernetica”: 0-1. In altri termini, sì-no, giusto-sbagliato, buono-cattivo, accetto-rifiuto, vero-falso: una consuetudine, ormai, che è nemica della libertà di pensiero e che si fonda soltanto sul pregiudizio personale e sull’isterismo collettivo. Anche la scrittura prevede una contrazione di un eventuale analisi del testo e della sua pubblicazione a 140-280 caratteri, che non è soltanto quello che potrebbe sembrare un allenamento al riassunto, ma diventa la pulsione alla battuta d’effetto, un impulso emotivo, una provocazione viscerale: un “pensiero miniaturizzato” che non prevede nessuna elaborazione e tantomeno quel dubbio che è alla base di qualsiasi confronto strutturato.
Il rifiuto della fatica di pensare e la conseguente perdita delle competenze cognitive produce quel fenomeno particolarmente inquietante e fastidioso che è la presunzione.

È sproporzionato rievocare Socrate e il suo “So di non sapere”, perché sarebbe sufficiente che ognuno prendesse semplicemente atto delle proprie competenze, e a queste si attenesse. Più facile a dirsi che a farsi in un sistema democratico dove 1 vale 1, e tutti pretendono il diritto di intervenire su ogni argomento.
Paolo Crepet riconosce questo valore egualitario soltanto nel contesto elettorale, ma lo nega drasticamente in qualunque altra occasione in cui debba essere riconosciuta la preparazione specifica, l’esperienza pratica e il curriculum professionale.
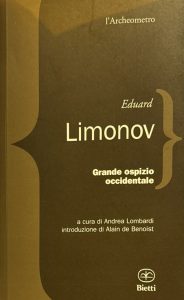
Personalmente, vado anche oltre a questa determinazione. In un saggio che si potrebbe inquadrare tra la filosofia politica e la psicologia di massa dal titolo “Grande ospizio occidentale”, il grande Eduard Limonov precisa – a mio avviso giustamente – che “per avere un’opinione propria, bisogna anzitutto desiderarlo. […] L’indipendenza mentale presuppone la riflessione, l’accesso a una informazione ‘qualificata’ [difficile da raggiungere in un black-out cognitivo democratico in cui] la schiacciante maggioranza della popolazione dell’Ospizio si limita invece a opinioni emotive binarie: odio o amore”. Per questi ed altri motivi, condivido appieno la considerazione di Limonov quando sottolinea come “Il fatto che solo un numero di individui abbia il tempo, la voglia e la capacità di pensare dovrebbe azzerare l’importanza del rituale elettorale”.

Da che parte cominciare ad educare al pensiero e, di conseguenza, alla libertà? Crepet mette in evidenza un tempo e un luogo specifici: la giovinezza e la scuola. È lì, per usare le parole dell’importante fondatore della psicologia archetipica, James Hillman, che deve iniziare l’addestramento fondativo del carattere della personalità, e rendersi conto che “Pensiero e anche lavoro: duro lavoro. E anche una sorta di devozione o rigore”.
Questo tempo, conferma sempre Crepet, esige un’azione radicale contro tutto ciò che è “smart” – agile, rapido, semplice, furbo – dalla città all’università, dall’apprendimento alla comunicazione, dal cinema alla lettura, e un ritorno consapevole alla ricerca, all’approfondimento, alla tenacia e al sacrificio.
Per usare una metafora poetica, l’esercizio di quella volontà inflessibile che al comodo belato del gregge omologato preferisce il rischioso ululato del branco differenziato.